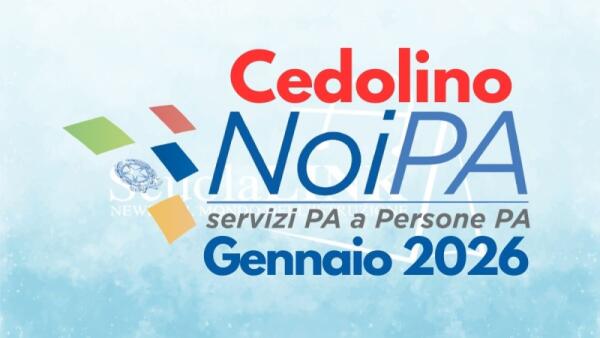Inclusione scolastica: il caso Firenze e i modelli europei
Dopo i fatti di Firenze, serve una riforma dell'inclusione scolastica che guardi ai sistemi europei più efficaci e strutturati.

Il recente caso di Firenze solleva dubbi urgenti sull'efficacia dell'inclusione scolastica in Italia. Le famiglie che protestano contro un alunno difficile evidenziano un sistema privo di risorse adeguate. L'episodio non è isolato e richiede una riforma strutturale immediata.
Il caso di Firenze come campanello d’allarme: serve un nuovo modello europeo di inclusione scolastica
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per l’episodio avvenuto in una scuola primaria di Firenze, dove un gruppo di famiglie ha scelto di non mandare i propri figli a scuola per protestare contro la presenza di un compagno con gravi difficoltà comportamentali. La vicenda, che segue casi analoghi registrati a Treviso e a Taranto, evidenzia una criticità strutturale del nostro sistema educativo: la mancanza di risorse, strumenti e figure specializzate in grado di affrontare in modo tempestivo e competente situazioni di disagio relazionale e aggressività infantile.
Il CNDDU ribadisce che la scuola deve restare un luogo di inclusione, non di esclusione, ma per esserlo davvero ha bisogno di sostegno concreto. Le scuole italiane, troppo spesso, si trovano a gestire emergenze educative senza una rete integrata di supporto. È necessario adottare un modello ispirato alle migliori pratiche europee, che unisca tutela della sicurezza, benessere psicologico e diritto all’apprendimento di tutti.
In Finlandia, per esempio, esiste un sistema di supporto a tre livelli che prevede interventi mirati e progressivi in base ai bisogni specifici dell’alunno, evitando stigmatizzazioni e favorendo la collaborazione tra insegnanti, psicologi e famiglie. In Belgio, centri di orientamento scolastico e psicologico (CLB) affiancano costantemente le scuole, offrendo consulenza gratuita e continua ad alunni, genitori e docenti. Nei Paesi Bassi, il principio del “dovere di cura” impone alle istituzioni scolastiche e ai consorzi territoriali di individuare sempre una soluzione educativa adeguata per ciascun bambino, con fondi dedicati e procedure snelle.
Anche in Francia si è affermato un modello flessibile, attraverso le cosiddette “ULIS”, unità didattiche di supporto che permettono di conciliare l’inclusione con percorsi personalizzati e temporanei, evitando l’allontanamento dell’alunno dal contesto scolastico. In Irlanda, il Servizio Nazionale di Psicologia Educativa (NEPS) assicura una presenza stabile di professionisti formati sul trauma, sul comportamento e sul benessere, mentre in Portogallo i “territori educativi di intervento prioritario” finanziano progetti pluriennali per le scuole che operano in contesti difficili, promuovendo la corresponsabilità tra comunità e istituzioni.
Questi modelli mostrano che l’inclusione autentica non è frutto di improvvisazione o buona volontà, ma di politiche strutturate e integrate. L’Italia deve intraprendere la stessa direzione, istituendo équipe multiprofessionali permanenti, formate da psicologi, pedagogisti ed educatori, che operino su base territoriale in raccordo con i servizi sociali e sanitari. È necessario creare un fondo nazionale per l’emergenza educativa che consenta di intervenire rapidamente nei casi più complessi, senza lasciare gli insegnanti e le famiglie soli di fronte al disagio.
La formazione dei docenti deve diventare un pilastro strategico: occorre promuovere competenze di gestione del comportamento, tecniche di mediazione dei conflitti e approcci didattici ispirati alla psicologia del trauma. Allo stesso modo, le famiglie devono essere coinvolte in percorsi di educazione alla genitorialità consapevole e alla corresponsabilità educativa, perché solo una comunità educante unita può affrontare efficacemente la complessità del presente.
Il CNDDU propone inoltre di sperimentare in Italia pratiche di giustizia riparativa, mediazione tra pari e tutoraggio studente-studente, già ampiamente adottate in Spagna e nel Nord Europa, per ridurre la conflittualità e promuovere la cultura del dialogo. Parallelamente, è fondamentale sviluppare un sistema di monitoraggio nazionale che rilevi in tempo reale le situazioni di rischio comportamentale e attivi task force specializzate entro pochi giorni.
La vicenda fiorentina non deve trasformarsi in un episodio di contrapposizione, ma in un’occasione di rinnovamento culturale. Il diritto all’inclusione e quello alla sicurezza non sono in conflitto, ma si rafforzano reciprocamente quando vengono affrontati in un quadro di solidarietà, formazione e cooperazione tra istituzioni.
Solo una scuola sostenuta da un sistema di aiuti reale, stabile e condiviso potrà davvero essere il luogo in cui ogni bambino – anche quello che soffre o reagisce con aggressività – possa sentirsi accolto, compreso e guidato verso una crescita consapevole e serena.
prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU