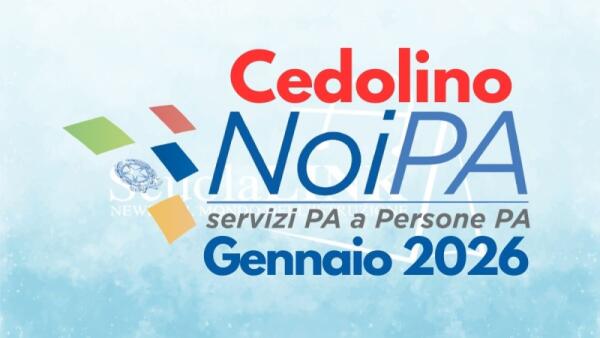L’università italiana tra tagli e precarietà, FLC CGIL: 'Nuovo DdL-truffa sui concorsi universitari'
Università italiana e nuovo Dl sul reclutamento, che elimina l’Abilitazione Scientifica Nazionale e introduce criteri discrezionali, peggiorando la precarietà.

Tagli e precarietà dell'Università italiana: è emergenza! - Il sistema universitario italiano sta affrontando una grave crisi strutturale. Con dimensioni ridotte rispetto alla media europea, un rapporto studenti-docenti tra i peggiori (1 docente ogni 20 studenti, contro una media europea di 1 ogni 14) e finanziamenti sotto l’1% del PIL (la media UE è dell’1,5%), l’università pubblica è messa a dura prova. Alla fine dei fondi PNRR si aggiungono il rischio di espulsione per oltre 40.000 precari – tra RTDa, assegnisti e borsisti – e tagli alla spesa pubblica, compresi quelli al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). In questo contesto, il Governo Meloni e la Ministra dell’Università Bernini hanno annunciato un nuovo disegno di legge che mira a modificare profondamente i criteri di accesso e reclutamento nella docenza universitaria, suscitando forti critiche.
Università italiana e nuovo DdL sull’accesso alla docenza: tra riforma e ritorno al passato
Il disegno di legge, formalmente denominato “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”, si presenta con l’obiettivo dichiarato di rendere il sistema di reclutamento più meritocratico e trasparente. Tuttavia, l’effetto principale è l’abolizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), sostituita da nuovi criteri quantitativi e automatizzati proposti dall’ANVUR, che mantengono inalterata la logica delle soglie minime e del publish or perish. I candidati dovranno dimostrare requisiti di produttività tramite una piattaforma ministeriale, che valuterà pubblicazioni, partecipazioni a convegni, progetti e altri titoli secondo parametri oggettivi, ma potenzialmente distorsivi.
Le commissioni locali tornano centrali nella selezione, con nuove prove didattiche e colloqui orali obbligatori anche per chi ha già esperienza universitaria. Questi elementi reintroducono margini di discrezionalità, eliminati nelle riforme precedenti per ridurre i favoritismi e garantire maggiore imparzialità. Il sistema rischia quindi di favorire logiche localistiche, accentuando le disparità tra atenei e limitando l’accesso trasparente ai ruoli accademici.
Effetti pratici e criticità della riforma sull'università italiana: mobilità fittizia e valutazioni ridondanti
La nuova proposta legislativa prevede anche misure sulla mobilità tra università, che consentono ai docenti a tempo indeterminato da almeno cinque anni di trasferirsi con l’assenso delle università coinvolte. Tuttavia, l’assenza di nuove risorse rende questi trasferimenti difficili da attuare. Le valutazioni periodiche della produttività dei docenti, legate persino agli scatti stipendiali, appaiono come una duplicazione della VQR, già esistente, con il rischio di sovraccaricare il personale e creare nuove forme di competizione interna.
Inoltre, l’eliminazione dell’obbligo per almeno un terzo dei Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B (RTTb) di avere esperienze in altri atenei indebolisce ulteriormente la mobilità accademica, rendendo meno efficace il contrasto ai meccanismi di autoreferenzialità. I vincoli previsti appaiono così più simbolici che sostanziali, offrendo solo un’apparente apertura verso standard internazionali, ma mantenendo inalterati i problemi strutturali.
Un disegno di legge criticato da tutta la comunità accademica
Le organizzazioni universitarie e sindacali, tra cui FLC CGIL e ADI, hanno espresso forti perplessità sul nuovo DdL, definendolo un “ddl-truffa” che scambia l’assenza di investimenti pubblici con una maggiore discrezionalità nelle assunzioni, favorendo una selezione elitaria e poco trasparente. La mancanza di un piano per la stabilizzazione dei precari e l’assenza di investimenti strutturali vengono letti come segnali di una volontà politica di contenere i costi, piuttosto che rafforzare il sistema universitario.
Il rischio, secondo gli esperti, è di tornare a un modello verticistico e competitivo, dove pochi “fortunati” riescono ad accedere ai ruoli accademici mentre la maggior parte dei ricercatori resta intrappolata in una condizione di precarietà cronica. In un contesto già segnato dalla crescita degli atenei telematici e profit, il disegno di legge rafforza un modello di università di classe, in contrasto con i principi di accesso pubblico e meritocratico che dovrebbero guidare un sistema universitario democratico.